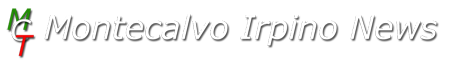Era un legame forte quello tra il Maestro Roberto De Simone, scomparso ieri all’età di 91 anni e l’Irpinia. Un legame evidente nella passione del musicologo e regista partenopeo per le tradizioni del territorio, per la cultura popolare irpina, a partire dalle zeza la tarantella montecalvese fino a canti politici registrati in alta irpinia a Montecalvo Irpino con l'aiuto del ricercatore e appassionato del luogo Prof. Angelo Siciliano, Aniello Russo e il cantore Felice Cristino e fiabe popolari. Più volte spiegherà di essere stato conquistato dalla ricchezza di canti e tradizione abbondanti in una zona come l'Irpinia,
Era un legame forte quello tra il Maestro Roberto De Simone, scomparso ieri all’età di 91 anni e l’Irpinia. Un legame evidente nella passione del musicologo e regista partenopeo per le tradizioni del territorio, per la cultura popolare irpina, a partire dalle zeza la tarantella montecalvese fino a canti politici registrati in alta irpinia a Montecalvo Irpino con l'aiuto del ricercatore e appassionato del luogo Prof. Angelo Siciliano, Aniello Russo e il cantore Felice Cristino e fiabe popolari. Più volte spiegherà di essere stato conquistato dalla ricchezza di canti e tradizione abbondanti in una zona come l'Irpinia,
materiale dichiarato nel 1974 patrimonio storico-culturale della regione Campania. Studioso sul campo tra il 1967 e il 1986. Lo sguardo era rivolto a quel territorio dove esisteva « una cultura dell’immaginario collettivo non ancora totalmente disgregata». A curare le illustrazioni delle opere di De Simone un irpino doc, il maestro Gennaro Vallifuoco, dalle “Fiabe Campane”, pubblicate da Einaudi nel 1994, “Il presepe popolare napoletano”, Einaudi, 1997, “Il Pentamerone, o Lo Cunto de li Cunti, di G. B. Basile nella riscrittura di Roberto De Simone”, Einaudi, 2002, “Son sei sorelle. Rituali e canti della tradizione campana”, Squilibri 2010.
Fino alla scenografia per l’opera lirica “Il Re Bello” di Roberto De Simone, al teatro La Pergola di Firenze nel 2004. Un legame consolidato dall’amicizia con lo storico delle tradizioni popolari Aniello Russo. Più volte aveva voluto essere presente in Irpinia per presentare gli studi di Russo dedicati alla cultura popolare irpina. Il pomeriggio di sabato, 29 luglio 2006, potrà essere ricordato per un evento importante, relativamente a quel che resta dei canti contadini montecalvesi. L’etnomusicologo napoletano Roberto De Simone, accompagnato da due collaboratori e dallo scrittore irpino Aniello Russo, arriva a Montecalvo da Napoli, per registrare

(De Simone a Montecalvo Irpino insieme al cantore Felice Cristino)
alcuni canti contadini. Lui aveva avuto modo di ascoltarli, tramite l’amico comune Russo, e si era dichiarato interessato ad alcuni di essi, in particolare quelli cantati da Felice Cristino, Pannucciéddru, e aveva espresso il desiderio di volerli registrare a sua volta, nell’ambito della ricerca che sta conducendo attualmente sui canti popolari nell’Irpinia e nella Campania. in campagna, in contrada Frascino, a casa di Felice Cristino, la cui disponibilità è sempre encomiabile, attendeva il maestro per cantare i canti che gli sarebbero stati richiesti. Roberto De Simone che, negli anni Settanta, era già passato per Montecalvo con Annabella Rossi, per registrare alcuni canti, stavolta ha scelto i seguenti tre canti: il canto funebre Tatìllu miju; il poema Angelica; il Canto comunista del 1946. Si tratta di tre canti differenti, per contenuto e melodia, ma che rappresentano, sicuramente meglio di altri, la tipicità di ciò che cantavano i nostri antenati e che è pervenuto sino a noi. Va detto però che alla scomparsa della civiltà contadina, in buona parte già avvenuta, si accompagna inevitabilmente la sparizione di queste ultime testimonianze, a volte ludiche, altre volte tristi, che scandivano la vita dei nostri avi e sopravvivono ormai solo come relitti, grazie agli ultimi anziani, cantatori dialettofoni. Da alcuni decenni non si canta più durante i lavori nei campi, perché la maggior parte delle attività agricole è meccanizzata. Non si canta durante le faccende domestiche, perché gli elettrodomestici hanno invaso anche le case di campagna, contribuendo all’isolamento delle persone. Non s’intonano più ninne nanne per i bimbi. Non si ‘portano’ serenate alle innamorate. Non si canta di notte, nel rientro a casa in campagna col buio pesto, per scacciare la paura degli spiriti, delle janare e dei lupi mannari, perché anche chi vive in campagna adesso si sposta in auto. Insomma stiamo assistendo agli ultimi sussulti di una civiltà che ha resistito e si è tramandata per secoli, e a cui il consumismo ha dato il colpo di grazia. Roberto De Simone non è solamente etnomusicologo, ma è anche pianista, compositore, autore e regista teatrale e di opere liriche. Oltre che per il Teatro San Carlo di Napoli, ha lavorato per la Scala di Milano e per altri importanti teatri italiani. È stato direttore del Conservatorio musicale di Napoli e ha una vastissima bibliografia di opere pubblicate, anche con editori nazionali come l’Einaudi. Da 46 anni fa ricerca sul campo e sorprende come questo suo lungo cammino, nel territorio della musica popolare, la cui geografia più che essersi rarefatta si è andata desertificando, lo abbia portato ad un’essenzialità estrema. Per lui, oggi ciò che conta è il canto registrato con la semplice voce dell’informatore. Viene fissato per sempre il preciso momento, in cui l’informatore ha fatto ricorso alla propria memoria per recuperare e ricreare, attraverso il canto, momenti di vita vissuta, oggi non più riproducibili con altri strumenti. Secondo lui anche la trascrizione del testo musicale è altra cosa, perché attiene alla letteratura, alla glottologia e all’antropologia, e non potrà mai consentire la ricreazione fonica precisa di timbri sonori, parole dialettali e fonemi. Se potrà essere consolante, per noi e per i posteri, alcune testimonianze canore resteranno sicuramente negli archivi dei musei etnografici e delle fondazioni create appositamente per la raccolta di questi ‘reperti’, facenti parte a pieno titolo della cultura orale. Ciò che è sconsolante, nella nostra civiltà dei consumi, è l’uso e l’abuso che ne fanno, di questi reperti sonori, alcuni ricercatori e gruppi folk. Con la scusa di riproporli, ridando ad essi linfa, li stravolgono completamente. Prendendoli a pretesto ne fanno varianti e variazioni, procedure consentite in ambito musicale, solo ai solisti di jazz. In un certo senso, ne viene fatto mercimonio. E ciò lo si riscontra sia nelle feste popolari che in certe rassegne di musica folk, anche di un certo livello. Si può dire che ciò a cui oggi capita di assistere, era consentito solo al poeta contadino, perché lui viveva il “suo tempo” nel suo ambiente rurale e pastorale, e poteva creare nuovi canti, o modificare quelli esistenti, perché non veniva meno la sua fedeltà ad un canone preciso che gli era fornito dalla tradizione, dal modo di vivere della sua gente, oltre che dagli usi e costumi. La sua etnia capiva i nuovi canti, che erano accettati, cantati e perduravano nel tempo. Le rielaborazioni artificiose o pretestuose, che si fanno oggi di quei canti, lasciano il vuoto dietro di sé. Roberto De Simone, dopo aver ultimato la registrazione dei tre canti, ha confidato che sarebbe disposto a tornare a Montecalvo, nel prossimo autunno, se due o tre contadine montecalvesi si rendessero disponibili a cantare e a fargli registrare i loro canti. Una raccolta più di cento canti a Montecalvo, classificati in oltre dieci gruppi: poema ANGELICA, stornelli, serenate, ninne nanne, canti pettegoli, epici, sociali (politici, di lavoro, del contrabbando), su animali, funebri, religiosi, semipopolari, parodistici, maccheronici o satirici. Purtroppo alcuni cantori, come Domenico Iorillo, Trancucciéddru, Pompilia Isabella, Angela Pisani e Giovanni Cristino, non sono più tra noi. Affetto dalla malattia di Parkinson, De Simone è morto nella sua casa di via Foria a Napoli il 6 aprile 2025, all'età di 91 anni. La camera ardente è stata allestita all'interno del foyer del Teatro di San Carlo dal pomeriggio dell'8 aprile, mentre i funerali si sono svolti il giorno successivo nel Duomo di Napoli, celebrati dal cardinale arcivescovo della città, Domenico Battaglia. Gli omaggi della città per De Simone sono stati numerosi: già nei giorni precedenti, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, e il prefetto di Napoli Michele di Bari hanno espresso il loro rispetto per il maestro. Peppe Barra, Enzo Gragnaniello, Isa Danieli, e molti altri artisti e personalità culturali si sono uniti per rendere omaggio a De Simone. Il cardinale Battaglia ha ricordato nell'omelia: «Oggi non siamo qui per dire addio. Siamo qui per dire grazie a un uomo di arte, di cultura, di fede. Siamo qui per dire il nostro grazie al maestro Roberto De Simone». Battaglia evidenziò come De Simone abbia «smontato e ricomposto la musica napoletana, l'ha studiata con rigore, l'ha contaminata con nuove forme espressive, l'ha elevata a patrimonio universaleᄏ.
Peppe Barra, arrivando in Duomo, ha dichiarato: «Tutto quello che sono lo devo in gran parte a Roberto De Simone perché è stato il mio mentore, il mio maestro e soprattutto mio grande amico. Penso che Napoli abbia perduto una grande fetta di cultura, non solo della città. Roberto era conosciuto in tutta Europa, era veramente un grande personaggio e persona meravigliosa che purtroppo non abbiamo più». Oltre a lui, anche l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e altre figure di rilievo come Mario Martone, Eugenio Bennato, Isa Danieli, Nino D'Angelo e molti altri rappresentanti del mondo della musica e della cultura napoletana presero parte alla cerimonia. Un lungo applauso ha salutato il feretro del maestro Roberto De Simone al termine delle esequie, simbolo del profondo legame che l'artista aveva creato con la sua città e il suo popolo. Sul piazzale cattedrale vi fu anche la breve esibizione di una tammorra, un omaggio alla carriera di De Simone. Nell'apertura delle esequie, l'orchestra del Conservatorio ha eseguito un brano in onore del maestro. Roberto De Simone è stato uno dei più grandi interpreti della cultura popolare napoletana, con un'opera che ha saputo raccontare e valorizzare la storia musicale e teatrale di Napoli. La sua eredità culturale continua a vivere attraverso le sue composizioni, le sue pubblicazioni e il suo impegno verso la tradizione e la ricerca storica. De Simone ha lasciato un segno indelebile nella città di Napoli e nel panorama culturale internazionale.
* Appendice
I visitatori dal 30/11/2002 fino ad oggi sono: